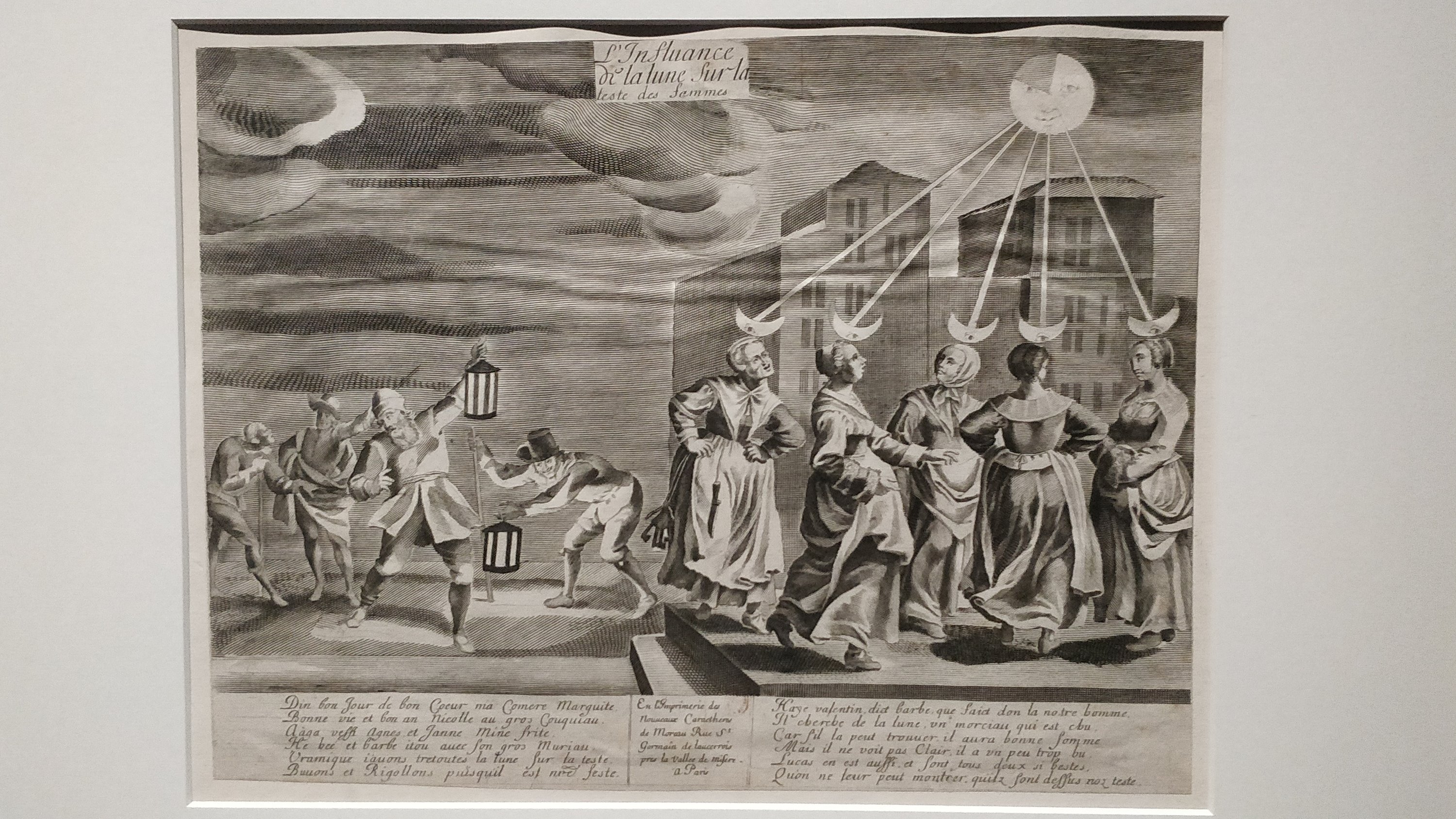Se l’essenza dell’indagine dell’arte concettuale è quella di fare luce sulla modalità più intima attraverso cui l’arte stessa si configura come dispositivo per la comprensione del mondo, allora il lavoro di Alain Fleischer può definirsi in modo eminente concettuale. Ma questo aggettivo assume qui i caratteri più nobili, essendo del tutto privo di quell’astratta e gelida connotazione di sterilità che spesso alcuni detrattori gli associano. L’esame che l’artista compie del suo mezzo espressivo non va, in altri termini, a detrimento della sua capacità espressiva, e questo in breve può essere considerato il miglior complimento che si possa pensare per questa mostra: L’image qui revient al Musée de la photographie Charles Nègre di Nizza dal 14 giugno al 29 settembre 2019.
La domanda fondamentale che Fleischer si pone è cosa sia l’immagine, qui articolata nel confronto tra movimento e stasi – quindi all’intersezione dei due più significativi mezzi artistici connessi alla modernità tecnologica occidentale: la fotografia e il cinema. Non tanto curiosamente la risposta sarà la stessa che altre forme di indagine artistica hanno raggiunto nel corso dei millenni di sviluppo del pensiero umano; cambiano le forme e le modalità certamente, ma non le verità di base della natura umana, e come potrebbe essere altrimenti?

Happy Days
Su una scala più ridotta, nella cronologia della carriera di Fleischer, già la serie Happy Days (1986-1988) definisce un articolato percorso estetico e ideologico che contiene in sé stesso il risultato ultimo dell’indagine. Le fotografie sono ottenute attraverso il movimento di un piccolo specchio che riflette parzialmente il contenuto di un’immagine (la riproduzione di famosi dipinti a tema femminile, quali ad esempio La Maya Desnuda). Lo specchio è mosso da un piccolo pupazzo a molla, la cui bandierina ha la scritta “Happy Days”; grazie alla lunga esposizione la camera cattura ciò che lo specchio riflette componendo una immagine complessiva (la riproduzione del quadro) invisibile all’occhio che assiste all’esperimento. Questa evocazione fantasmatica di un’assenza è il cuore della creazione delle immagini e del senso ad esse associato. Solo la presenza di un osservatore le trae dal nulla in cui giacciono; solo il dispositivo fotografico fissa nella stasi dell’istante la somma degli attimi del moto dello specchio.

Immagine e oggetto
Il gioco di prestigio di Fleischer ha anche un’ironia provocatoria per i nostri sensi: la gabbia che racchiude un uccello materializzato con il trucco di Happy Days è un oggetto che esiste al di là della finzione del movimento. Il suo ruolo è quello di catalizzatore medianico per un’altra dimensione, quasi il fuscello del rabdomante per l’artista che opera la sua resurrezione fotografica. Analogamente la proiezione di Autant en emporte le vent (1979) ha un’essenza necromantica: il filmato del volto di una donna con i capelli mossi dal vento è proiettato su un ventilatore in movimento. Le sue pale creano il flusso d’aria che è fissato nella sequenza, così sentiamo allo stesso tempo l’effetto che vediamo rappresentato. La brezza che ci sfiora è la stessa che è fissata su pellicola, l’evocazione di qualcosa che non c’è.

Autant en emporte le vent
Lo scarto tra segno e simbolo è il crepaccio dentro cui precipitiamo non sempre con gli esiti migliori. Il tentativo di tradurre la traccia sonora di un film, nella sua letterale rappresentazione di onda di pressione, in un oggetto fotografabile – Je ne suis qu’une image (2016) – appare più una sterile stilizzazione che il divertissement che era forse inteso. Le conchiglie o i paesaggi montani frastagliati come l’onda sonora che il loro profilo rappresenta hanno l’anonima inconsistenza della natura astratta. Allo stesso tempo, nella loro intenzione mimetica mancata di un soffio, probabilmente al di là delle intenzioni, ci mostrano l’artificiosità di tutta la concezione naturale, trasformata dalla rappresentazione umana in una somma infinita di intenzioni simboliche. È quindi paradossale che l’opera artisticamente meno riuscita sia quella concettualmente più significativa: nell’indagine sul senso dell’immagine ritroviamo il senso dell’osservare umano.

Je ne suis qu’une image
Le ombre che le lenzuola de L’homme dans les draps (2000) disegnano sono volti umani pur nella loro completa casualità di costruzione. Quello che non è casuale è l’osservatore, sempre umano, troppo umano. Come per le nuvole che interrogate sulle proprie forme rispondono sempre con cose stupefacenti e così prossime a colui che pone la domanda. Perché la risposta che Fleischer cerca è già contenuta nella domanda: l’arte è l’uomo che scruta se stesso.
Marco Gandolfi Ama l’arte. Prova a condividere l’amore.